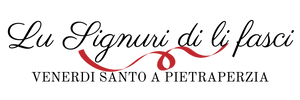LA PROCESSIONE DEL VENERDI SANTO
“Lu Signùri di li fasci” è una stupenda traduzione scenica dell’ascesa alla spiritualità. A Dio, un antico Crocifisso risplendente di luci, si giunge lungo una trave di cipresso alta più di otto metri collocata su una vara che ne consente, durante la processione serale, il trasporto a spalla.
L’imponente simulacro è costituito da una trave di legno di cipresso alta metri 8,51 – equivalenti a 33 palmi siciliani -, oltre la vara alta circa metri 1,5 che termina con una croce, realizzata nel 1905, dall’artigiano pietrino Vincenzo Marrocco.
Il singolare nome dato alla processione deriva dalle numerose fasce di lino bianco che i devoti possessori legano al cerchio di ferro collocato nella parte superiore della trave, sotto un globo policromo posto ai piedi del SS. Crocifisso.
La chiesa del Carmine, e il Crocifisso in essa custodito, il giorno del venerdì santo diventano il centro e la meta di tutti i Pietrini.
La chiesa venne edificata nel quindicesimo secolo ad opera degli Agostiniani, venuti a Pietraperzia da Palermo dove la devozione alla Madonna del Soccorso era nata nel 1306 ad opera del frate Nicolò La Bruna.
La chiesa è curata dalla Confraternita Maria Ss. del Soccorso eretta prima dell’anno 1584. Si hanno di essa notizie certe dal testamento della principessa Giulia Moncada moglie del principe Pietro Barresi che lasciò parte dei suoi beni alla Confraternita allo scopo di dotare una figlia orfana di confrate scelta a sorte nel numero di 12 nella solennità principale della Confraternita l’8 settembre di ogni anno.
All’interno della chiesa si conservano, oltre alla statua della Madonna del Soccorso, un tempo portata in processione l’otto settembre, una tela raffigurante S. Silvestro Papa, un’altra tela raffigurante l’elemosina di S. Agostino ed inoltre la statua della Madonna del Carmelo, oggetto di devozione nel mese di luglio.
Il Crocifisso venerato dalla comunità pietrina è probabilmente opera quattro-cinquecentesca in legno di sorbo. Alcuni studiosi ne attribuiscono la realizzazione ad uno scultore della famiglia Matinati di Messina.
Lo storico dell’arte Paolo Russo ha datato l’opera d’arte tra la fine del 1400 e i primi anni del secolo successivo.
Dalle prime ore del mattino del Venerdì Santo fervono i preparativi per la processione serale.
All’interno della chiesa viene sistemata l’antica croce – che nel 1904 si spezzò durante la processione – sulla quale verrà posto nel pomeriggio il Crocifisso, per l’omaggio dei fedeli e la benedizione delle “misuredde”.
Alle ore 15.00, dalla cappella dove è custodito, i confrati della Confraternita Maria SS. del Soccorso – organizzatrice e gelosa custode della tradizione – depongono il Crocifisso ligneo, alto cm. 120, che la sera, poco prima dell’inizio della processione, viene fissato sulla croce.
Nella chiesa gremita di fedeli silenziosi si leva in quel momento l’angosciante l’invocazione dei confrati: “Pietà e misericordia Signùri”.
Da questo momento il Crocifisso diviene il polo attorno a cui gravita l’intera Pietraperzia.
Il Crocifisso viere portato in chiesa Madre per il rito dello svelamento della croce e inizia così l’omaggio del popolo pietrino che dura tutto il pomeriggio.
Ritornati nella chiesa del Carmine inizia l’omaggio del popolo pietrino con il tradizionale rito della benedizione delle “misuredde”. I fedeli sfilano davanti al Crocifisso portando a benedire, secondo un’antica tradizione, un nastro di colore rosso – il colore della Passione di Cristo – della misura del corpo del Crocifisso, sul quale viene misurato, da cui appunto il nome di “misuredda”, cioè una piccola misura.
La “misuredda” viene legata ad un braccio in segno di protezione e viene conservata dai fedeli durante tutto l’anno. Scorre così nella chiesa del Carmine il grande fiume della speranza.
Al tramonto la croce e la vara vengono portate nella piazza antistante la chiesa del Carmine e collocate in posizione orizzontale per consentire la legatura delle circa 150 fasce di lino di proprietà dei fedeli Pietrini. Tutto si svolge con ordine e devozione.
Inizia il montaggio del fercolo che viene posizionato nel preciso posto in cui avverrà l’alzata, una sagoma quadrata già predisposta nella pavimentazione della piazza Carmine.
Le circa 150 fasce che vengono legate ogni anno alla Croce mediante un cerchio metallico, formato da 2 semicerchi, sono strisce di lino bianco della lunghezza di circa 33 metri e della larghezza di circa 40 cm., annodate a metà della loro lunghezza complessiva, producendo in tal modo il loro raddoppiamento
Esse servono ad equilibrare l’alta Croce, durante la processione. Un tempo ai piedi di “lu Cravaniu” – come era denominato anticamente lu Signuri di li fasci – venivano legate solo poche fasce. In una stampa risalente al 1861 se ne intravedono solo sei.
La fascia, al di là del puro fatto fisico dell’equilibrio del fercolo, ha un significato molto più profondo.
Essa rappresenta, per il fedele Pietrino, una promessa, un voto, un legame con il passato e con i propri cari, che la realizzarono per devozione e che durante la loro vita la legarono ai piedi del Crocifisso, lasciandola in eredità ai loro familiari che, per rispettare un antico voto e per fede, continuano ad attaccarla ancora oggi.
Una delle più antiche fasce, realizzata con lino coltivato e intessuto a Pietraperzia, porta incisa a ricamo la data del 1888. Ogni fascia contiene almeno le iniziali del primo proprietario e spesso l’anno di realizzazione. Le circa 450 fasce esistenti a Pietraperzia rappresentano per ogni proprietario un legame a Cristo per sempre e in maniera indissolubile. Un tesoro da tramandare di padre in figlio.
Questa lunga striscia di lino bianco rappresenta un legame tra l’uomo ed il Figlio di Dio morto in Croce per redimere gli uomini.
Ai piedi del SS. Crocifisso poco prima dell’alzata della Croce viene posto un globo sfaccettato con vetri colorati, simbolo del mondo e delle sue diversità. L’effetto scenografico è veramente suggestivo.
La croce attuale è stata realizzata nel 1905, dopo che l’anno precedente durante la processione, la parte terminale della lunga Croce si spezzò scivolando sopra le fasce e il miracoloso Crocifisso fu prelevato da un sacerdote prima che raggiungesse il suolo.
La costernazione dei fedeli fu grande, ma la Confraternita non si perse d’animo ed immediatamente si adoperò affinché un nuovo fercolo fosse approntato per l’anno seguente.
Il valente falegname pietrino Vincenzo Marrocco ebbe l’incarico dal Governatore della Confraternita Filippo Di Gregorio di ricavare da un albero di cipresso – tagliato per l’occasione in contrada Don Cola – la nuova croce tuttora in uso.
L’attuale vara è stata realizzata nel 1989 dal falegname pietrino Salvatore Vitale, in sostituzione della precedente dopo la rottura avvenuta nello stesso anno.
Durante la processione di quell’anno, quando il fercolo di “lu Signuri di li fasci” stava per raggiungere la piazza antistante la chiesa Madre si udì uno scricchiolio.
La processione fu interrotta, mentre il fercolo veniva posto in posizione orizzontale per accertare la possibilità di riparare il danno. Ogni tentativo risultò vano poiché i supporti metallici che avrebbero dovuto sostenere la vara al momento dell’alzata, cedettero e il fercolo scivolò sulle braccia dei fedeli.
Grande fu la commozione dei fedeli quando, non potendosi continuare la processione, il fercolo, in posizione orizzontale, venne riportato nella chiesa di appartenenza.
Il Crocifisso, che da secoli volge lo sguardo sofferente verso la comunità di Pietraperzia, permise di evitare danni peggiori.
Al termine della fase di legatura delle fasce, circa 150 ogni anno, ma altre 300 non vengono legate per effetto della turnazione, vengono, in ultimo, montati i raggi che formano l’aureola ed infine “lu munnu” un globo di legno e vetri colorati, illuminato internamente, simbolo di universalità, che dà a tutto l’insieme un aspetto originalissimo.
Quando ogni fascia è stata annodata, i confrati si dispongono in chiesa uno accanto all’altro per pregare prima del “passamano” e, perpetuando l’antico rito, con sincronico e commovente passaggio dalle braccia di uno a quelle di un altro, permettono al Crocifisso di giungere all’esterno della chiesa dove viene agganciato alla Croce pronta per essere innalzata.
Il SS. Crocifisso viene posto dal Governatore della Confraternita sulla Croce, mentre dei fiori bianchi, che ogni anno arrivano da parte di anonimi fedeli, vengono posti ai piedi del SS. Crocifisso.
Il sacerdote invita i presenti a pregare ricordando a tutti l’ora in cui il Cristo fu messo in croce per espiare i peccati del mondo.
L’attenzione degli astanti si pone ora sul Confrate guida, in attesa del segnale che tutti attendono, mentre il silenzio avvolge l’intera piazza.
Il momento richiede la massima attenzione.
Con lo sguardo volto ad accertarsi che le fasce siano state sistemate in modo equilibrato e che ognuno sia al posto giusto, il Confrate guida batte tre colpi sulla “vara” e, come un guizzo di luce bianca, la Croce è posta in posizione verticale pronta per iniziare la processione. Nella piazza del Carmine echeggiano i tre colpi di martello battuti sulla vara, quasi a simboleggiare i tre colpi di martello che inchiodarono Gesù Cristo alla Croce.
Rapida come un tuffo al cuore l’altissima Croce, “attrantata” cioè tirata con forza dalle centinaia di fasce, emerge maestosa dal mare di fedeli assiepati intorno.
Appena alzato il fercolo si erge in tutta la sua maestosità. L’immagine delle innumerevoli e candide fasce nel suo insieme si trasforma in una stilizzazione del corpo.
Lo spettacolo è di bellezza incomparabile. Nel buio della notte l’immensa e immacolata cuspide risplende di una luce lattiginosa, quasi soprannaturale e con essa risplendono gli occhi di molti fedeli commossi.
Nel momento in cui viene alzato, il fercolo diviene un complesso vivente, attivo, composto non da materia inerte, ma bensì da persone che, unite nel trasporto del Cristo in croce, si fondono fino a creare un corpo unico.
Scrive Giancarlo Santi: “…. mi sembrò che lu Signuri di li fasci fosse una miniera inesplorata di profondi contenuti e simboli sacri. In particolare m’impressionò moltissimo il silenzioso messaggio inviato da quelle fasce tese tra una moltitudine di uomini sparsi intorno ed il Signore centro unificatore del mondo”.
Durante il rito echeggia di continuo la lancinante invocazione “Pietà e Misericordia Signùri”. Spesso, se la Pasqua è bassa, l’aria in cui si diffondono queste dolci e terribili parole è gelida ed a un certo punto non si capisce se chi assiste trema per il freddo o per l’emozione.
Mentre i possessori di fasce si adoperano a disporsi nei loro settori, i portatori – fedeli dotati di forza fisica e di altrettanta fede – provvedono a prelevare le aste e ad acconciare il fercolo per la partenza.
La processione, aperta dalla Confraternita Maria SS. del Soccorso, segue un ordine prestabilito e consolidato nel corso dei secoli.
Il fercolo di “lu Signuri di li fasci” inizia la processione, con una perfetta sincronia dei fedeli – circa 500 tra portatori e possessori di fasce – che ne consentono il movimento.
Nel suo procedere il Signore delle fasce cambia forma in funzione del luogo: ora si restringe e si allunga come una candida valanga nelle vie più strette; ora si allarga assumendo la tipica forma della montagna innevata nelle piazze e nelle strade più larghe.
Nello stesso tempo le Consorelle della Confraternita dell’Addolorata trasportano sul sagrato antistante la chiesa Madre il fercolo dell’Addolorata, che attenderà il passaggio sia del fercolo di lu Signuri di li fasci che dell’Urna con il Cristo morto, per accodarsi e chiudere la processione.
Il trasporto del fercolo dell’Addolorata a Pietraperzia è fatto dalle donne: fatto unico e significativo che sembra voler rappresentare il dolore femminile, il dolore per la perdita di un figlio che solo una mamma può comprendere. In Maria, infatti, si identifica tutto il dolore di una donna.
L’urna con il Cristo morto è opera del valente ebanista Filippo Panvini che la realizzò in stile baroccheggiante nel 1933, ed è stata restaurata nel 2009, riportandola all’antico splendore
A Pietraperzia, il fercolo dell’Addolorata è portato a spalla dalle Consorelle della Confraternita omonima, che durante il corso dell’anno cura la propria formazione spirituale con incontri di preghiera.
Questa Confraternita, fondata dal parroco don Antonino Assennato nel 1890, è stata ricostituita nella seconda metà degli anni ’90 del secolo scorso per volontà dell’attuale parroco don Giuseppe Rabita.
La processione percorre via Barone Tortorici e via Garibaldi.
Un giro particolare è quello che da via Garibaldi immette in via Rosolino Pilo.
Con una precisione millimetrica la guida della vara deve calcolare l’angolo del giro per consentire una perfetta manovra, pena il sovraccarico sulle spalle dei portatori e l’aggrovigliarsi delle fasce, con conseguente instabilità del fercolo.
I rifacimenti urbanistici atti a consentire il perfetto svolgersi della processione sono stati notevoli.
Banchine tolte, piazzole create per l’occasione, fili elettrici dell’impianto d’illuminazione pubblica spostati per consentire il passaggio del fercolo.
Interventi che ai non Pietrini possono apparire strani, ma “lu Signuri di li fasci” assurge per gli abitanti di Pietraperzia a simbolo della comunità locale e principale momento di aggregazione collettiva.
Nella preparazione della processione, infatti, esiste un rituale preciso e rigoroso, ricco di prescrizioni e di atti da cui nessuno può prescindere.
Le soste effettuate lungo il tragitto, normalmente ad ogni incrocio, consentono a chi non può uscire da casa di vedere il SS. Crocifisso e ai portatori una breve sosta.
I portatori sono il motore e l’anima del fercolo. Sono essi, infatti, con la loro forza fisica e spirituale, ad assorbire il peso e le sollecitazioni della “vara”, ma ciascuno di essi porta il fercolo per devozione e voto e da questa fede trae la forza necessaria per portare a termine la processione.
Durante la processione i confrati eseguono la ladata: un canto polivocale che narra la passione e morte di Gesù Cristo nella caratteristica esecuzione a tre voci e coro di accompagnamento. La ladata conserva ancora il suo fascino antico di canto popolare e viene eseguito dai confrati con atteggiamento di vissuta partecipazione alla vicenda terreno di Gesù Cristo.
Un tempo il canto veniva eseguito per le strade del paese da gruppi di “ladatura”, per lo più “jurnatara” cioè braccianti e gessai, oggi sostituiti dai confrati della confraternita Maria SS. del Soccorso, che, dall’anno 2001 si è assunta l’onere e l’onore di salvare e salvaguardare questo ricco patrimonio di fede e di cultura popolare.
Tramandata oralmente di padre in figlio essa è giunta fino a noi con tutto il fascino ed il pathos che riesce a creare.
Di grande suggestione i versi cantati dai confrati al termine della processione:
Lu scisiru di la Cruci e l’hanu datu
Mmrazza a l’Addilurata di Maria.
Maria chianciva lu sò Figliu amatu
“Cunfurtu di la mamma”cci diciva.
“Figliu di gloria, stinnardu aduratu
Quannu supra sti vrazza ti tiniva
Ora ti viju di sangu allagatu
Murtu senza di nuddu, a la strania”
I versi sono conosciuti anche in alcuni comuni limitrofi, come Caltanissetta, Resuttano e Milena. I versi cantati a Pietraperzia sono uguali a quelli di Caltanissetta dove un tempo i ladatori si recavano e dove erano apprezzati per la particolare melodia.
Da via Rosolino Pilo, il corteo passando per via Umberto e via La Masa, raggiunge piazza Vittorio Emanuele, dove il fercolo assume tutta la sua maestosità.
Le fasce bianche danno la sensazione ai presenti di assistere ad un avvenimento eccezionale: la visione di una montagna alta ed innevata sulla quale è posto un Crocifisso che si muove.
Capita ogni tanto che durante la processione si senta l’esortazione dei confrati ad aumentare o diminuire la trazione (“attrantammu li fasci” o “allintammu li fasci”) per richiamare l’attenzione dei possessori delle fasce per evitare lo sbilanciamento del percolo.
Il corteo si muove con lentezza e spagnolesca magnificenza dalla Piazza del Carmine per le vie del paese gremite di folla.
Dopo la piazza Vittorio Emanuele la processione imbocca la via Stefano Di Blasi. Il fercolo del Crocifisso prosegue, mentre gli altri due fercoli cambiano itinerario, per giungere al momento del giro al quadrivio della santa Croce, alle spalle di esso.
Giunto all’incrocio tra via Della Pace e via Di Blasi, il fercolo di “lu Signuri di li fasci”, compie un giro su sè stesso, con una manovra millimetrica, ruotando sull’asse di 180 gradi.
Attraversata nuovamente la via Stefano Di Blasi ed il corso Vittorio Emanuele, la processione prosegue per via Barone Tortorici, giungendo nella piazza antistante la chiesa Madre.
In questa luogo si realizza un secondo giro del fercolo per consentire alla Croce di assumere la stessa posizione che aveva al momento della partenza al fine di consentire la “calata”. Infatti deve essere abbassata nell’altra piazza, quella del Carmine, alle spalle della chiesa Madre, nell’apposito scalino necessario a fare da puntello alla vara.
Le fasce vengono allargate ed alzate e sotto di esse, per l’unica volta nel corso della processione, passano l’Urna che rientra nella chiesa del Carmine e l’Addolorata che rientra in chiesa Madre.
L’immagine della Vergine che guarda in alto il Cristo in croce è veramente toccante.
Il fercolo dell’Addolorata sosta ai piedi di lu Signuri di li fasci e viene eseguito dai confrati e dai portatori il canto “Ah si versate lacrime”.
Lu Signuri di li fasci, quindi, ritorna verso la chiesa del Carmine procedendo con le spalle in avanti.
Giunto in piazza Carmine il fercolo viene predisposto con meticolosa precisione nella sagoma esistente per essere abbassato.
Lentissimamente e fra il silenzio generale, al segnale del confrate guida, ha inizio la “calata” della Croce, mentre mille mani si protendono per ricevere e toccare un’ultima volta la statua del Crocifisso, in una sequenza rallentata, con le fasce tese nello sforzo di sostenere e di tirare per dare la giusta direzione alla Croce mentre viene abbassata.
Quest’ultima fase suscita una grande emozione tra i presenti che nel silenzio assoluto, partecipano alla manovra.
Decine sono le mani che si protendono nell’atto di toccare il Crocifisso, ed appena la croce viene deposta, grande è l’afflusso dei fedeli e dei portatori nella chiesa per rendere omaggio al Crocifisso che fino a qualche istante prima hanno portato sulle spalle.
L’anello di ferro a cui sono legate le fasce viene aperto e d’un colpo solo vengono tutte liberate.
Al momento del passaggio della processione nelle strade, quasi sempre allo stesso orario, qualcuno degli emigrati in America, telefona per ascoltare il mormorio sommesso e la voce dei portatori che invocano “Pietà e Misericordia Signùri” o ascoltare qualche brano della “ladata”.
Il legame alla secolare tradizione rimane forte anche se lontani nello spazio e nel tempo.
La processione dura circa cinque ore a motivo del percorso tradizionale effettuato e anche per le ripetute fermate, necessarie al riposo dei portatori del pesante fercolo, ma anche per permettere alle persone che non possono uscire da casa di vedere e pregare il SS. Crocifisso.
Le soste e le partenze sono segnate da tre colpi di martello battuti dal confrate – il maestro di vara – sulla vara stessa.
I portatori della vara – 80 giovani posti sotto due aste di legno incastrate nella suddetta vara – sanno di ricoprire un ruolo esclusivo: lo eseguono con estrema umiltà cedendo il posto a chi ne fa richiesta per un tratto di strada e lo stesso vale per i proprietari delle fasce.
Il legame alla secolare tradizione rimane forte anche se lontani nello spazio e nel tempo.
La processione è caratterizzata da una forte partecipazione popolare, testimonianza dalle migliaia di emigrati Pietrini che ritornano per l’occasione a Pietraperzia per adempiere al voto di portare “lu Signuri” o di attaccare la fascia ai piedi del SS. Crocifisso.
Al momento del passaggio della processione per le strade dell’antica cittadina, quasi sempre allo stesso orario, qualcuno degli emigrati che si trova negli Stati Uniti d’America o in America latina, telefona per ascoltare il mormorio sommesso dei fedeli e la voce dei portatori che invocano “Pietà e Misericordia Signuri”.
La processione ha termine poco dopo la mezzanotte, lasciando in tutti i partecipanti una grande stanchezza, alleviata dalla consapevolezza di avere adempiuto un rito tramandato da secoli, di cui tutti i Pietrini sono detentori.
Testo di Giuseppe Maddalena